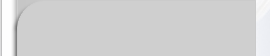|
|
||
|
|
Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP) AOP è una definizione che comprende diverse condizioni associate ad alterata perfusione e spesso ad ischemia periferica. L'arteriopatia che interessa prevalentemente gli arti inferiori è in genere dovuta ad arteriosclerosi (>95% dei casi). Quasi sempre l'arteriopatia è espressione di una malattia sistemica che coinvolge vari distretti vascolari incluso quello coronarico, splancnico, cerebrale). Nei pazienti affetti da AOP è sempre presente una arteriosclerosi diffusa per cui vanno sempre valutati i diversi distretti coronarico e cerebrale poiché in questo gruppo sono frequenti gli eventi cerebrovascolari (TIA, stroke, angina, IMA). L'insufficienza arteriosa periferica è dovuta ad una riduzione di flusso e pressione dovute al restringimento o all'occlusione di una arteria associata a sintomi caratteristici. Clinica. Occlusione arteriosa cronica: la più frequente. Il sintomo più frequente è la cosiddetta claudicatio intermittens che si manifesta con dolore e senso di fatica agli arti inferiori che insorge inizialmente durante lo sforzo e successivamente con il progredire della malattia anche a riposo. La distanza percorsa prima della comparsa del dolore varia da paziente a paziente ed è grosso modo correlata al grado ed al livello di ostruzione. La localizzazione del dolore può indicare il livello di interessamento (es. claudicatio della coscia depone per una lesione iliaca, claudicatio del polpaccio depone per una lesione femoro-poplitea) In uno stadio avanzato di malattia è possibile il manifestarsi di dolori anche a riposo dovuto all'ischemia con accumulo di metaboliti tossici. Il dolore è persistente e marcato, si attenua con l'arto declive, a penzoloni ed aumenta con il sollevamento. Dati nosografici importanti: 1) Notevole disparità tra coloro che accusano disturbi e coloro che sono asintomatici (questo è indice della subdolezza della malattia). 2) Arteriopatia sintomatica degli arti inferiori è presente nello 0.2-0.5% dei soggetti di età inferiore a 50 anni, raggiunge il 5% tra i soggetti di 50-65 anni e supera il 18% tra i soggetti di età superiore ai 65 anni. 3) Il rapporto tra maschi e femmine varia a seconda delle condizioni sociali ed ambientali (studio di Framingham M:F=4-5:1 in buona parte questi valori sono collegati alla diversa abitudine al fumo nel periodo interessato dallo studio. Attualmente la forbice si sta restringendo per il recupero di molte donne al fumo e per la precocità dell'abitudine allo stesso). 4) L'evoluzione della malattia se è prevedibile nel danno d'organo, non lo è per i tempi ed i modi nel senso che una lesione può stabilizzarsi per diversi anni o evolvere rapidamente verso l'ischemia severa. 5) Fattori prognostici: età di comparsa dei sintomi (tanto più grave è la malattia quanto più tardivo è l'esordio nel senso che > 75 a. rischio aumentato di amputazione), sesso maschile (< del gap), localizzazione delle lesioni (tanto più gravi quanto più distali), severità dei sintomi (claudicatio intermittens serrata --> 100 mt il 30% dei pazienti si aggrava entro 3 anni, allo stadio di ischemia critica il 60% dei pazienti va incontro a peggioramento ed il 20% va incontro entro un anno ad amputazione), fattori di rischio vascolari (spt. diabete e fumo, in particolare il fumo triplica il rischio di aggravamento e raddoppia il rischio di amputazione), negli operati di by-pass la persistenza dell'abitudine al fumo triplica il rischio di una grave ostruzione post-operatoria e riduce della metà la pervietà dei by-pass distali. 6) La prognosi è peggiore negli arteriopatici diabetici. Infatti la comparsa di ischemia critica risulta 3 volte più frequente in questi soggetti. 7) Ipertensione e dislipidemie sembrano influire in modo minore sulla prognosi a medio - lungo termine rispetto al diabete ed al fumo.
In < 10% dei casi la causa di morte dei pazienti con arteriopatia è imputabile ad aggravamento della malattia. La morbidità in effetti è legata soprattutto a diffusione e concomitanza della malattia aterosclerotica (di solito a livello coronarico, cerebrale, renale), tumori associati (in particolare polmonari) causati o associabili al fumo. E' necessario ricordare che almeno il 30-35% dei pazienti arteriopatici presenta una coronaropatia sintomatica. Il blocco della deambulazione è un meccanismo per cui un certo numero di coronaropatie che causerebbero angina da sforzo sono mascherate dalla forzata limitazione dello sforzo così come molti coronaropatici non camminano abbastanza per avere sintomi da claudicatio. Le lesioni coronariche sono più frequenti in quei pazienti nei quali l'arteriosclerosi si è manifestata più precocemente (prima dei 50 anni). Una arteriopatia associata ad alterazioni carotidee e coronariche si ritrova nel 7-10% dei casi. Ogni volta che si documenta una malattia vascolare clinicamente rilevante o anche subclinica in uno di questi distretti vascolari (carotideo-vertebrale, periferico, coronarico) bisogna dare per scontata la presenza di malattia che , in forma moderata o grave, sia presente negli altri sistemi. Mortalità. I pazienti con arteriopatia periferica hanno una spettanza di vita di 5-10 anni inferiore rispetto agli individui della stessa età. La mortalità a 10 anni nei pazienti con claudicatio intermittens è 3 volte superiore a quella dei pazienti asintomatici. Pazienti con ischemia critica hanno prognosi peggiore (20% muore entro un anno, il 50% entro 5 anni). Il diabete è considerato fattore aggravante. La localizzazione aorto-iliaca sembra essere maggiormente correlata all'abitudine al fumo. Il fumo aumenta da 3 a 5 volte la mortalità per infarto del miocardio nell'arteriopatico. La cardiopatia rappresenta la prima causa di morte negli arteriopatici (circa il 40-70% muore per cardiopatia ischemica, il 5-15% per un evento accidentale cerebrale, il 15-30%% muore per tumori almeno in parte associabili al tabacco). Impatto socioeconomico. Tenendo conto che il 65% dei pazienti è pensionato in quanto in età avanzata, il 15% dei pazienti deve interrompere la propria attività per marcata inabilità lavorativa, il 9% deve modificare la propria attività (cambiare lavoro o ridurre l'attività), il 50% è costretto ad interrompere il lavoro per 100-120 gg. mediamente all'anno. Il primo grande studio su vasta scala sui fattori di rischio coronarico è stato eseguito a Framingham a partire dal 1948 allo scopo di valutare alcuni fattori costituzionali e condizionanti associati allo sviluppo di malattie quali l'arteriosclerosi, ipertensione, ecc. osservando la popolazione asintomatica casualmente selezionata. Eziologia. A) Arteriopatie aterosclerotiche (95% dei casi)con localizzazione più frequente a livello dell'aorta sottorenale, origine delle iliache, biforcazione femorale ed in genere tutte le biforcazioni per la formazione di una placca ateromasica che progredisce dando luogo ad accumulo di lipidi e tessuto fibroso nello spessore della parete determinandone la riduzione di calibro fino ad ostruzione completa. La rottura della placca determina la dispersione di frammenti che possono dare luogo a fenomeni di embolizzazione periferica. B) arteriopatie infiammatorie (m. di Buerger, frequente nei giovani a carico delle arterie di piccolo e medio calibro, morbo di Takayasu, arterite di Horton). C) arteriti iatrogene (ergotamina, beta-bloccanti, attiniche, meccaniche, ecc.). Diagnostica strumentale. L'insufficienza arteriosa degli arti inferiori, sia acuta che cronica, può essere riconosciuta spesso già alla anamnesi in quanto i sintomi ed i segni clinici con i quali si manifesta sono tipici, tuttavia sono sempre necessarie indagini a conferma del dubbio clinico sia per problemi di ordine medico-legale che per quantificare l'entità del danno, l'effetto di un trattamento e per monitorare l'evoluzione nel tempo della lesione. Lo studio delle lesioni vascolari al giorno d'oggi si basa prevalentemente sulla diagnostica non invasiva limitando le tecniche invasive (arteriografia) nei casi da sottoporre ad intervento chirurgico in quanto consentono una precisa definizione topografica delle lesioni (sede e grado di ostruzione). In particolare l' ecocolordoppler con misurazione delle pressioni periferiche (indice caviglia-braccio - detto indice di Windsor), la pletismografia , il laserdoppler, la misurazione della PO2 transcutanea. Un primo semplice approccio allo studio del paziente con insufficienza arteriosa periferica è dato dalla misurazione delle pressioni periferiche. Con un Doppler si misurano le pressioni alle tibiali anteriori e posteriori (nei soggetti normali queste sono uguali o leggermente superiori alla pressione sistolica rilevata al braccio). Negli arteriopatici le pressioni periferiche saranno tanto più basse rispetto alla pressione sistolica quanto maggiore è il grado di ostruzione. Si può anche verificare il caso che non si rilevi flusso pulsatile a livello di una o più arterie distali. Nel caso le arterie siano calcifiche come accade nel diabetico per l'incompressibilità dei vasi le pressioni possono essere erroneamente alte. Lo studio dell'indice pressorio caviglia-braccio ha solo un valore indicativo della severità di malattia e si ottiene dal rapporto tra la pressione rilevata alla caviglia e quella rilevata al braccio ed è normalmente > 1, se ICB > 0,5 vi è ostruzione in una sola sede; se ICB < 0,5 è indice di ostruzioni su più livelli. In pazienti con claudicatio l' ICB è circa 0,6; nei pazienti con gangrena 0.05. Il Doppler è un misuratore della velocità di flusso. Per pressioni < 40 mmHg il segnale doppler è scadente e non attendibile per cui la misurazione delle pressioni dovrebbe essere eseguita solo con pletismografia strain-gauge. Il doppler è solo una metodica di screening. Tutte le metodiche non invasive oltre che essere utili per la diagnosi sono utili nel follow up sia in pazienti operati a cielo aperto che con angioplastica transluminale. Diagnosi differenziale. Osteoartrite, compressioni neurospinali (ernia del disco, stenosi spinale), TVP, traumi. Trattamento. Il trattamento iniziale è conservativo per la claudicatio, senza dolore a riposo e può risultare nel controllare o ridurre i segni e sintomi della malattia, in particolare l'associazione di esercizio fisico e l'abolizione del fumo possono avere un effetto evidente. La riduzione ed il controllo degli altri fattori di rischio (es. dislipidemia) può produrre ulteriori benefici in un periodo di tempo più lungo (mesi). Il trattamento medico risulta efficace nella maggior parte dei pazienti (PGE 1, pentossifillina, Buflomedil). In caso di ischemia critica (dolore a riposo, gangrena) un trattamento invasivo è considerato elettivo (rivascolarizzazione, angioplastica). La terapia standard di approccio è comunque medica con prostanoidi ad alte dosi che sembra, qualora non risolutivo, perlomeno determinare un miglioramento della sintomatologia e, spesso un livello più distale di amputazione. Chirurgia vascolare ed endovascolare, angioplastica e trattamento medico non sono in competizione ma costituiscono una combinazione di procedure che si susseguono nelle varie fasi della malattia in base alle caratteristiche del paziente, tenendo conto dell'età -più è giovane più si è aggressivi . Valutazione dell'efficacia della terapia. E' data dall'aumento della distanza percorribile senza dolore. In genere pazienti con claudicatio a 100-300 m. rispondono bene al trattamento medico mentre una distanza di marcia < 50-100 m. è spesso correlata ad uno stadio avanzato di malattia ed ad una più veloce progressione delle lesioni arteriose. Conclusioni. L'arteriopatia obliterante degli arti inferiori nelle sue varie forme è una malattia frequente la cui prevalenza è sottostimata. L'eziologia è rappresentata prevalentemente dalla arteriosclerosi che può essere in un buon numero di pazienti (30%) associata alla esistenza di diabete. La prognosi, sostanzialmente severa, dipende dalla diffusione della malattia. La morbidità/mortalità è in genere associata a coronaropatia, accidenti cerebrovascolari e tumori associati al fumo.
Ultimo Aggiornamento: 27/07/2008 20:15 |
|
|
|
|
|